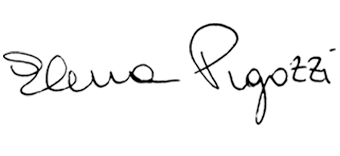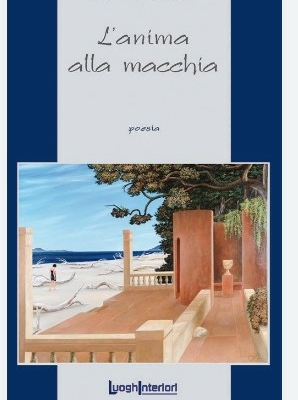“Non saprei di cosa parlare… Della morte o dell’amore? O magari è lo stesso?” Comincia con un interrogativo aperto, la cui risposta, se esiste, è il senso stesso della vita, uno dei libri imprescindibili del Novecento, Preghiera per Cernobyl, di Svetlana Aleksievič, Premio Nobel per la letteratura del 2015. Uscito sul finire del Novecento – 1997 – Preghiera per Cernobyl ha la forza del reportage e la ferocia dell’inchiesta, l’incisività del documento, l’autenticità della voce dei protagonisti. È al tempo stesso “romanzo corale”, testimonianza e prova di una tragedia del progresso e quindi dell’umanità intera, racconto epico di una terra, resoconto rigoroso di un disastro, poema in grado di far rivivere i sentimenti, gli umori, le atmosfere dello scoppio della centrale nucleare e della fine di un sistema politico e ideologico insieme.
Non è tutto. Preghiera per Cernobyl è anche il modello di un nuovo genere letterario, nel quale la realtà è il contenuto fondamentale della trama, costituita di testimonianze, interviste, monologhi. Un genere che l’Autrice riconduce ad Ales’ Adamovič, autore bielorusso che lei indica come il principale Maestro, e che è stato definito come “romanzo-oratorio”, “romanzo- testimonianza”, “prosa epico-corale”. Infatti, Preghiera è un testo nel quale i materiali autentici – fonti, documenti, testimonianze, interviste – appartengono al genere giornalistico e vengono assemblati dall’Autrice in una prosa che trasforma la materia, il contenuto, in un coro tragico, in una voce, che è costituita di tante voci, che supplicano e si interrogano, in una narrazione capace di condurre il lettore esattamente alla notte del 26 aprile del 1986 davanti alla quarta unità della centrale elettronucleare di Cernobyl e di fargli vivere – come esperienza “reale” e autentica – quanto successe all’indomani del più grande disastro atomico del dopoguerra. O meglio, del Novecento, se si escludono le esplosioni successive della centrale giapponese di Fukushima del 2011.
Chi scrive ha ricordato la lezione del correlativo oggettivo di Eliot, recuperato dal nostro Montale: sono gli “ingredienti” capaci di restituire le emozioni, il vissuto del fatto, dell’episodio.
“Questo libro – scrive infatti l’Autrice – non parla di Cernobyl in quanto tale, ma del suo mondo. Proprio di ciò che conosciamo meno. O quasi per niente. A interessarmi non era l’avvenimento in sé, vale a dire che cosa era successo e per colpa di chi, bensì le impressioni, i sentimenti delle persone, che hanno taccato con mano l’ignoto. Il mistero” Ciò che i fatti non includono, ma che ne costituiscono l’impalcatura, le fondamenta.
Con Preghiera c’è anche la voce di una terra che diventa protagonista e che si costituisce dei tanti testimoni, abitanti, protagonisti durante e dopo il disastro e che danno viso, corpo, umori e odori alla tragedia.
Altra grande novità della scrittrice e giornalista Aleksievič è di avere elevato i generi giornalistici dell’intervista e del documento a genere letterario. Inoltre, l’Autrice ha stravolto radicalmente il concetto stesso di romanzo storico per affermare con forza il bisogno di un romanzo vero, lontano dal “verosimile” e quindi autentico, che faccia della grande storia e delle piccole storie i tasselli della propria narrazione, lasciando all’Autore lo spazio di sistemazione, di assemblaggio degli stessi nuclei di realtà. In questo modo il racconto diventa un documento di verità, come lo è stato Storia di una colonna infame, nel quale i documenti si fanno ricostruzione processuale e atto d’accusa verso un’epoca e un’umanità impaurita e ignorante. Così in Preghiera l’atto d’accusa è verso l’era atomica e un progresso che fa delle armi di distruzione di massa il proprio perfezionamento.
Cernobyl, scrive l’Autrice a commento del suo romanzo, “cambiò il mondo. Cambiò il nemico. La morte ebbe facce nuove che non conoscevamo ancora. Non si vedeva, la morte, non si toccava, non aveva odore. Mancavano persino le parole per raccontare della gente che aveva paura dell’acqua, della terra, dei fiori, degli alberi. Perché niente di simile era mai accaduto, prima.”
Una riflessione lucida che, a distanza di quindici anni, la porta ad affermare: “Pensavo di avere scritto del passato. Invece era il futuro.”
Preghiera per Cernobyl oggi più che mai è uno di quei testi chiave del nostro futuro e del nostro martoriato presente.

Emanuela Monti, ritratto
È una parola affilata, capace di incidere il dolore e mostrarne la ferita. Una parola che non si concede sconti e rifugge la facile consolazione. L’anima alla macchia, raccolta di poesie di Emanuela Monti (Luoghi Interiori editore, vincitore del “Premio Città di Castello” 2018), guida il lettore nei grovigli di un cuore infranto, ne scandaglia l’animo con precisione chirurgica e restituisce immagini senza sbavature, ma così perfette da impedire ogni fraintendimento.
Nelle liriche L’anima alla macchia il verso poetico diventa sonda che porta alla luce antiche ruggini, come ne L’ospizio: mite, ubbidiente/ ma dura, più di sempre/ nel silenzio caparbio/ nel rifiutarmi/ un accenno di sorriso; ma anche lama capace di tagliare eredità di ingiustizie e pregiudizi, come in Quarta generazione: tre generazioni di maschi./ Tre generazioni di male. Alla terza casca l’albero/ alla quarta si spezza la catena.
E ancora, aspra la lingua/ che mi fa eco, in Magna Grecia, nella quale la parola di Monti stana quell’anima che si dà alla macchia, mentre il paesaggio sembra acuire il distacco, rendere più dolorosa la lacerazione – Deserta la spiaggia d’agosto/ Asciutta la lingua/che batte dove il dente duole – diventare specchio stesso del dolore.
Solo il verso poetico, quando si fa cadenza di ritmo, si fa suono che ritorna – Latra la tramontana (in Gennaio) -, accompagna la ricerca, o meglio la perlustrazione di un’anima “alla macchia” ed è, forse, la vera consolazione che la poetessa Monti si concede.
L’anima alla macchia trasforma il dolore in canto, è poesia che diventa musica, e che della musica conosce i ritmi e le armonie. Poesia che è capace di costruire interessanti assonanze e allitterazioni, evocare echi sonori dalla misura classica e restituire un
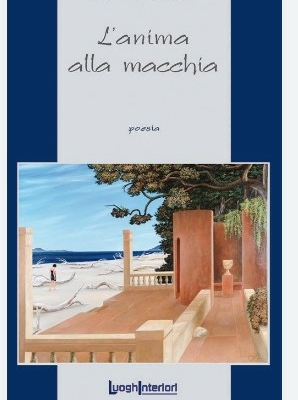
“L’anima alla macchia” – Emanuela Monti
tessuto fonico che è il vero balsamo che dà conforto.
Diverso invece è il ruolo del paesaggio, che, si legga ancora Gennaio, diventa specchio di un animo dolente: E la brina bianca/luccica nella notte/ come occhi di morti.
Oppure Aprile: la terra è desolata: / stenta, a ingoiare l’inverno.
O si legga lo splendido Il vestito corallo, nel quale l’abito si fa metafora della perdita. Cadono le gocce di cristallo/ tracce del tuo sudore/ tracce del tuo umore. (…) Che si disperde/ gocciola via/ nel solstizio d’estate.
Caproni definiva il poeta un minatore ed è quanto si avverte nei versi di Monti, quello scavo continuo per mettere a nudo anima e cuore senza concedere sconti, ma con il coraggio della parola potente, capace di giungere al fondo della materia pulsante e altrettanto coraggiosa nel mostrarne l’assenza di senso, confermando che il fuggire dell’anima sia un prendere atto del fallimento della ragione, della sua incapacità di trovare un senso al dolore. Non viene una madre. /Non esce una preghiera. Inascoltato/ il balbettio di pianto.